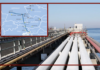ITALIA – Roma 25/11/2013. L’America è in crisi, è un dato di fatto. Crisi economica globale, bolle finanziarie, scarsità di petrolio e inflazione galoppante stanno facendo del mandato presidenziale di Mr. Cool, come Stefano Pistolini, Il Foglio, definisce Barak Obama, uno dei più difficili della storia americana.
ITALIA – Roma 25/11/2013. L’America è in crisi, è un dato di fatto. Crisi economica globale, bolle finanziarie, scarsità di petrolio e inflazione galoppante stanno facendo del mandato presidenziale di Mr. Cool, come Stefano Pistolini, Il Foglio, definisce Barak Obama, uno dei più difficili della storia americana.
C’è uno sporco lavoro da fare ed Obama sembra l’uomo giusto al momento giusto. Prima di tutto ridurre il deficit di bilancio dello stato, politica poco condivisa dai super ricchi. L’1% più ricco d’America è rimasto fermo sulle sue posizioni contrarie al “fiscal cliff” e rappresenta la fetta del paese più ostile alle politiche obamiane. «Osama Bin Laden è morto e la General Motors è viva» diceva Joe Biden per difendere Obama dalle arringhe dei repubblicani. In secondo luogo, fare il punto della situazione del pantano afgano e ridare slancio all’economia USA che da tempo sembra rincorrere quella cinese.
Se è vero che il nostro MR. Cool si è trovato in una situazione a dir poco terribile è vero anche che il precedente inquilino della Casa Bianca si preoccupò molto poco di lasciare una buona eredità al suo successore. Kevin Phillips in “La Teocrazia Americana” mette in luce tre fattori strettamente collegati fra loro che hanno fatto della presidenza Bush 2001-2008: petrolio, religione e indebitamento.
Gli Stati Uniti d’America sono sempre stati una potenza petrolifera. Dagli inizi del XIX secolo, quando vennero scoperti i primi giacimenti, si intuì subito il largo uso che si poteva fare di quella materia prima che presto avrebbe rimpiazzato il carbone. Le due guerre mondiali videro primeggiare gli USA proprio per il loro approvvigionamento illimitato di petrolio; potendo contare su una vasta area di approvvigionamento gas-petrolifero, gli americani hanno inoltre costruito la più grande cultura automobilistica al mondo e sono abituati ad avere benzina, gas da cucina ed elettricità ad un presso molto basso. In una parola, il petrolio entrò a far parte dell’American Way of Life. Nel lontano 1956 Marion King Hubbert, geologo americano che lavorava per una delle “sette sorelle”, la Shell, pubblicò una serie di calcoli che mettevano in relazione la data di scoperta dei pozzi petroliferi e il picco produttivo che ne sarebbe derivato. In breve, il concetto di picco di Hubbert prevede che quando si è estratta la metà del pozzo di petrolio, ogni barile in più estratto verrà a costare di più del suo prezzo; ergo la produttività del pozzo diminuirà. Secondo gli esperti, molti dei pozzi americani (escludendo quelli in Alaska) hanno ormai raggiunto il picco. Questo fattore insieme alla fatiscenza dei macchinari e alle arretrate tecniche estrattive è stata proprio la causa che ha spinto i presidenti americani a cercare approvvigionamenti in altre zone del globo a partire dagli anni Settanta.
In questo quadro si capisce quanto la parola “Iraq” suonasse come sinonimo di salvezza per i giganti petroliferi americani già nel 1991. Dopo l’amministrazione Clinton che come tutte le amministrazioni democratiche si caratterizzò per la sua timidezza in politica estera, i magnati del petrolio videro nel texano George Walker il candidato perfetto per ripartire all’arrembaggio dei pozzi mondiali. L’unico problema era accattivarsi l’elettorato che fino ad allora era stato paralizzato dalla così detta “sindrome del Vietnam”, che fece dimenticare a più di una generazione di americani le prodezze in politica estera. Il destino arrise ai repubblicani quando l’11 Settembre 2001 ci fu l’attentato alle torri gemelle: quale momento migliore per mettere le mani su una zona strategica come il Medioriente?
In questo contesto la cosa che ha allarmato Phillips è stata la “texificazione” dell’America, ossia il sovrapporsi di entità politica repubblicana e grande capacità energetica degli Stati dell’Unione, proprio come lo stato del Texas, timorato di Dio, nazionalista e pieno di petrolio.
 Il secondo fattore toccato da Phillips è proprio quello della religione. Dai tempi dei Padri Pellegrini l’America si sente la nazione eletta da Dio, che in Suo nome è destinata a dispensare democrazia e libertà al resto del mondo, la «city upon a hill» faro nelle tenebre di puritana memoria. Ebbene non è certo un caso che la fazione repubblicana, al fine di aggiudicarsi un ricco bacino di voti, abbia sposato delle politiche di impronta fortemente religiosa. Negli ultimi anni infatti il radicalismo religioso negli Stati Uniti ha registrato un forte balzo in avanti grazie alle innumerevoli associazioni religiose (per non dire vere e proprie sette), tra le quali la Convenzione Battista del Sud, che hanno abbracciato l’antimodernismo culturale, schierandosi contro la ricerca scientifica sulle cellule staminali; sentimenti guerrafondai, e coltivato le profezie sull’Armageddon, ossia la battaglia finale tra il Bene e il Male che si concluderà con la fine del mondo e la sconfitta del Male. Kevin Phillips infatti è convinto che questo fenomeno sia da considerarsi di primaria importanza perché i popoli che sono eccessivamente devoti si lasciano trasportare con facilità dalle scritture sacre, un atteggiamento troppo pericoloso – avverte Phillips – per una grande potenza mondiale come quella degli USA. L’invasione dell’Iraq infatti è stata considerata come una mossa alquanto azzardata, dettata secondo i politologi, da una parte da un fervente animosità religiosa che vedeva la guerra in quella parte di mondo come la sconfitta definitiva del Male secondo le Sacre Scritture; dall’altra dalla bramosità di giganti petroliferi di cui Bush junior si è fatto portavoce. Secondo quanto Alan Wolfe scrive nel suo libro “Ritorno alla Grandezza”, l’ostilità dell’amministrazione Bush verso la storia non ha precedenti nella storia. Bush infatti ha fatto di tutto per non ascoltare l’esperienza accumulata dai suoi predecessori e dagli avvertimenti del dipartimento di stato, il tutto facendo affidamento sulla sua incrollabile fede e sulla lobby petrolifera. Tutt’oggi tra le fila del GOP (Grand Old Party), ovvero dei repubblicani, sfilano ancora numerosi i credenti. «Senza il contributo dei credenti quello conservatore sarebbe ancora un movimento minoritario», per dirla con le parole di Alan Wolfe.
Il secondo fattore toccato da Phillips è proprio quello della religione. Dai tempi dei Padri Pellegrini l’America si sente la nazione eletta da Dio, che in Suo nome è destinata a dispensare democrazia e libertà al resto del mondo, la «city upon a hill» faro nelle tenebre di puritana memoria. Ebbene non è certo un caso che la fazione repubblicana, al fine di aggiudicarsi un ricco bacino di voti, abbia sposato delle politiche di impronta fortemente religiosa. Negli ultimi anni infatti il radicalismo religioso negli Stati Uniti ha registrato un forte balzo in avanti grazie alle innumerevoli associazioni religiose (per non dire vere e proprie sette), tra le quali la Convenzione Battista del Sud, che hanno abbracciato l’antimodernismo culturale, schierandosi contro la ricerca scientifica sulle cellule staminali; sentimenti guerrafondai, e coltivato le profezie sull’Armageddon, ossia la battaglia finale tra il Bene e il Male che si concluderà con la fine del mondo e la sconfitta del Male. Kevin Phillips infatti è convinto che questo fenomeno sia da considerarsi di primaria importanza perché i popoli che sono eccessivamente devoti si lasciano trasportare con facilità dalle scritture sacre, un atteggiamento troppo pericoloso – avverte Phillips – per una grande potenza mondiale come quella degli USA. L’invasione dell’Iraq infatti è stata considerata come una mossa alquanto azzardata, dettata secondo i politologi, da una parte da un fervente animosità religiosa che vedeva la guerra in quella parte di mondo come la sconfitta definitiva del Male secondo le Sacre Scritture; dall’altra dalla bramosità di giganti petroliferi di cui Bush junior si è fatto portavoce. Secondo quanto Alan Wolfe scrive nel suo libro “Ritorno alla Grandezza”, l’ostilità dell’amministrazione Bush verso la storia non ha precedenti nella storia. Bush infatti ha fatto di tutto per non ascoltare l’esperienza accumulata dai suoi predecessori e dagli avvertimenti del dipartimento di stato, il tutto facendo affidamento sulla sua incrollabile fede e sulla lobby petrolifera. Tutt’oggi tra le fila del GOP (Grand Old Party), ovvero dei repubblicani, sfilano ancora numerosi i credenti. «Senza il contributo dei credenti quello conservatore sarebbe ancora un movimento minoritario», per dirla con le parole di Alan Wolfe.
Ultimo pezzo del puzzle, nonché cavallo di battaglia della campagna elettorale repubblicana, sono stati i tagli fiscali. I conservatori hanno infatti visto nel candidato George W. un revival del presidente Reagan che con i suoi tagli fiscali da una parte e l’aumento della spesa pubblica dall’altra, aveva già contribuito ad indebitare le tasche del Tesoro. Negli anni 2000 la corrente politica “Leave Us Alone”, come è stata chiamata dall’attivista conservatore Grover Norquist, ha preso piede primeggiando di fatto con l’elezione di Bush. Tagliando l’imposta sui redditi da capitale, «Bush ha detto chiaramente – scrive Gore Vidal in “Democrazia Tradita” – che è favorevole al socialismo per i ricchi e per la libera impresa per i poveri», ovvero chi ha meno bisogno del governo ha la possibilità di ottenere il massimo appoggio, mentre coloro che hanno meno risorse devono affrontare il libero mercato competitivo. «Gli enormi deficit prodotti dai tagli fiscali e dai costosi aiuti alle imprese, scrive Alan Wolfe, trattano il futuro con la stessa scarsa considerazione con cui l’amministrazione Bush guarda al passato». 
Resta da aggiungere la grande bolla finanziaria di cui, insieme all’amministrazione Bush, è stato responsabile anche Alan Greenspan, amministratore capo della Federal Reserve fino al 2006. Lo storico del consumo Peter Stearns ha descritto lo schema mentale della bolla finanziaria pre 911: «Nel 2001 più di metà degli americani non avevano praticamente risparmi e un terzo viveva a credito sulla prossima busta paga, spesso invischiato in un oneroso debito al consumo». Questa bolla finanziaria inoltre è stata aggravata dal fatto che la finanza ha fatto più gola della produzione di beni materiali. Scrive Phillips: «Negli USA le industrie produttrici di beni commerciali attirano sempre meno investimenti, perché in altri settori si possono ottenere profitti molto più elevati. Nel 2004 investitori e imprese statunitensi hanno guadagnato dei loro investimenti all’estero quasi il doppio di quanto gli investitori esteri abbiano ricavato dai loro investimenti negli Stati Uniti».
La politica monetaria di Greenspan seguì le tracce della deregulation degli anni Novanta, quando era opinione diffusa tra i banchieri che gli Stati Uniti, frenati da una struttura bancaria vecchia e frammentata, avessero bisogno di super-banche capaci di saltare i confini statali, lasciandosi alle spalle, come dice Phillips nel suo libro, la vecchia separazione (risalente agli anni Trenta) fra settore bancario, settore degli investimenti e delle assicurazioni, in modo da poter competere con i giganteschi conglomerati finanziari di Giappone, Inghilterra, Francia, Svizzera e Germania.
Scaricare tutta la responsabilità su questi signori però non giova a comprendere il fenomeno. Bisogna considerare infatti che il debito era entrato nella menti del cittadino americano; indebitarsi per comprare un SUV nuovo o rifinanziare la propria ipoteca, il tutto con un finanziamento a tasso zero, significava per i cittadini partecipare alla lotta del paese contro il terrorismo. Dopo l’11 Settembre alcune madri di famiglia intervistate dichiaravano di sentirsi più sicure a viaggiare in un SUV, per l’incolumità dei propri figli. < Lo zio Sam vuole che tu sottoscriva un prestito>. Questo è oggi il messaggio da tempo di guerra, scrive Phillips, assai diverso da quello lanciato durante le due guerre mondiali.
Ed è proprio di “stato di guerra” che Gore Vidal parla in “Democrazia Tradita”, facendo riflettere sul fatto che solo in tempo di guerra l’esecutivo può conquistare il massimo del potere sul popolo, «sostituendo pesi e contrappesi dalla Costituzione con un apparato d’emergenza chiamato Sicurezza Nazionale». Ed è questo che a detta di Gore Vidal, George W. Bush ha fatto agli USA, «egli ha dichiarato tutto da solo una guerra al terrorismo, idea insensata come quella di una guerra alla forfora».
Anche Alan Wolfe non rinuncia alla sua arringa nei confronti dell’amministrazione Bush: «Tutti i leader politici fingono, ma il presidente Bush ha portato quest’arte a livelli mai visti (…). In ogni campo della sfera politica, il miscuglio di segretezza e dichiarazioni false dell’amministrazione mirava ad approfittare del fatto che al di fuori dei circoli esclusivi di Washington mancavano informazioni dettagliate sulle scelte politiche». Per Wolfe i presidenti americani si dividono in quelli che scelgono la via della grandezza e quelli che invece prediligono quella della bontà, come George W. Il campo a favore della bontà è unito nella convinzione che un governo forte e progetti ambiziosi guasteranno i valori che l’America ha sempre avuto cari e che l’hanno resa eccezionale. Impegnarsi nel raggiungimento dell’ideale del bene significa tentare di raggiungere la perfezione; gli americani devono quindi prima essere virtuosi e lavarsi dai loro peccati prima di andare in giro per il mondo a diffondere il loro messaggio. I fautori di un’America grande ritengono invece che nessun’idea, per quanto nobile in teoria, abbia grande significato se non si ha abbastanza potere politico per vederla realizzata in pratica; aver piegato principi e talvolta leggi verrà dimenticato una volta che i risultati raggiunti splenderanno nel loro successo, misurato in base alla potenza militare, il PIL e l’eguaglianza sociale piuttosto che sulla purezza degli animi. «Con la rielezione di Bush nel 2004 gli americani hanno scelto di continuare a credere di essere un popolo speciale eletto da Dio e destinato a grandi cose, poco importa se il resto del mondo li considera prigionieri della loro stessa innocenza», sentenzia Wolfe. «Se gli americani vogliono vivere in un grande paese, continua Wolfe, devono comportarsi come se la grandezza sia qualcosa che meritano. Al momento, non sono all’altezza del compito». Tuttavia è probabile che la sconfitta in Iraq finisca per assumere i caratteri che quella in Vietnam si è rivelata per il democratici, una vera e propria sindrome. Questo fattore ridarebbe credibilità ai liberal, portandoli di nuovo alla ribalta. L’elezione di Obama in questo quadro appena descritto assume caratteri provvidenzialistici e forse è proprio quello di cui Wolfe senta la mancanza e ciò che egli chiede al popolo americano: ritornare alla grandezza.