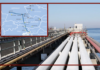Oltre 5mila nuovi casi l’anno. Con il 25% delle diagnosi ottenute in via “casuale” e il 70% di essi scoperto in fase avanzata, vista la mancanza di segnali specifici.
Il colangiocarcinoma, tumore delle vie biliari, è un tipo di tumore primitivo del fegato che ha origine dai colangiociti, cellule che rivestono i dotti che trasportano la bile dal fegato all’intestino.
«Si tratta di una patologia rara – spiega Lorenza Rimassa, professore associato di Oncologia medica a Humanitas University, IRCCS Humanitas Research Hospital di Rozzano (Milano) – ma in costante crescita. Si distingue, in base alla sua sede d’insorgenza, in intraepatico – qualora si sviluppi internamente al fegato – ed extraepatico se nasce dalle vie biliari extraepatiche».
Le forme intraepatiche vengono identificate nei pazienti colpiti da malattie alle vie biliari, ovvero la colangite sclerosante primitiva e i calcoli biliari. E proprio su queste, in crescita nei Paesi dell’Occidente, incidono gli stili di vita non corretti. I fattori di rischio possono essere riassunti con la sindrome metabolica, l’obesità, la steatosi e la cirrosi epatica, l’epatopatia cronica, il consumo esagerato di alcool (abuso) e, non è certo una novità, il fumo di sigaretta. Tuttavia nella maggioranza dei casi è difficile dire con assoluta certezza quale sia la causa specifica.
Come avviene la diagnosi? Gli specialisti affermano sia più semplice nelle forme “al di fuori del fegato”. Caratterizzate, molto spesso, da un colorito giallo della cute e delle sclere in relazione all’accumulo della bilirubina nel sangue, urine scure, feci biancastre e prurito (innalzamento del livello dei sali biliari nel sangue). Di contro, il colangiocarcinoma intraepatico solitamente è “silenzioso” (asintomatico) per lunghi periodi e i sintomi d’esordio – ovvero dolori all’addome, perdita di peso, nausea e malessere generalizzato – risultano aspecifici.
«Ecco perché – aggiunge la professoressa Rimassa – quasi un quarto dei casi di carcinoma intraepatico è in modo accidentale, come può accadere a conclusione di un’eco addominale fatta per altri motivi. Possono passare sei mesi dalla comparsa della sintomatologia alla diagnosi certa».
Rimassa rimarca quindi l’essenzialità di un vero e proprio cambio culturale attraverso l’avvio di campagne di sensibilizzazione rivolte a tutti i medici non specialisti – a cominciare dai medici di base, di famiglia – utili ad accrescere il livello di conoscenze su questa neoplasia davvero aggressiva. «Solo così – commenta – potremo migliorare (accorciare?) i tempi diagnostici».
Altra nota dolente, la sopravvivenza dei pazienti: a 5 anni è appena del 17% negli individui di sesso maschile e ancora più bassa – il 15% – nelle donne (si arriva però al 50% se la malattia viene riscontrata in stadio precoce).
Le soluzioni? Sotto il profilo chirurgico, se l’intervento si effettua nello stadio iniziale, l’esito può essere definitivo.
«Purtroppo – dichiara Alfredo Guglielmi, professore ordinario di Chirurgia generale ed Epatobiliare all’Università di Verona – soltanto il 25% dei pazienti è candidato alla sala operatoria. L’intervento è difficile e richiede l’impiego di tecniche avanzate, chirurghi con formazione ad hoc, team multidisciplinari e centri ad altissima specializzazione».
In numerosi casi, nel post-intervento si ricorre alla chemioterapia precauzionale. Diverso il discorso per chi non accede alla chirurgia e nei quali la malattia è tornata: il trattamento in prima battuta è dato dalla chemioterapia «a breve associata all’immunoterapia che seppur non risolutiva contribuisce a controllare l’evoluzione del tumore».
Marco Valeriani